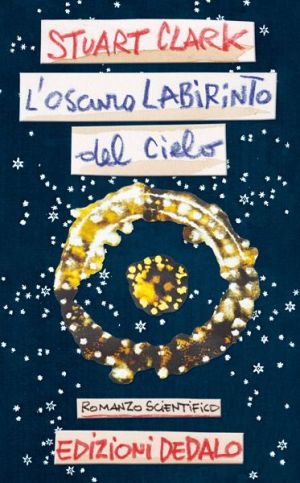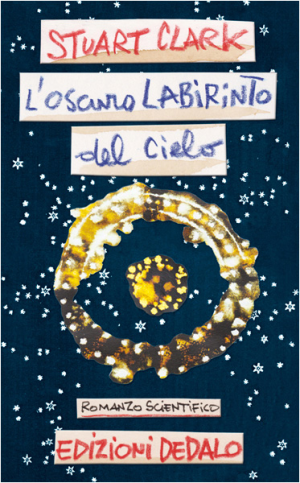Alla ricerca di una nuova Terra
Esopianeti, esplorazioni spaziali e vita extraterrestre
L’umanità si trova a un punto di svolta nell’esplorazione dello spazio: i pianeti extrasolari esistono, ma ce ne sono in grado di ospitare la vita?
- Collana: ScienzaFACILE
- ISBN: 9788822068774
- Anno: 2018
- Mese: aprile
- Formato: 14 x 21 cm
- Pagine: 216
- Tag: Scienza Astronomia Universo Astrofisica
Con uno stile coinvolgente e un ritmo incalzante, l’astrofisico Stuart Clark racconta la tormentata e appassionante storia della ricerca di pianeti simili alla Terra fuori dal Sistema Solare. Dopo innumerevoli falsi allarmi, il primo esopianeta in orbita attorno a una stella diversa dal Sole è stato scoperto nel 1995. Oggi, poco più di due decenni dopo, i pianeti extrasolari scovati dai ricercatori sono centinaia. Alcuni sono più neri del carbone, altri sono paesaggi infernali ricoperti di lava ardente; alcuni sono perennemente devastati da venti simili a uragani, altri ruotano intorno non a una sola stella, bensì a due.
Anche quando hanno dimensioni analoghe alla Terra, la maggior parte dei mondi scoperti è davvero aliena, molto diversa dal nostro pianeta blu. Gli astronomi, però, hanno individuato decine di pianeti simili a Giove, a Nettuno o persino a Mercurio, in orbita attorno a stelle come il Sole. La scoperta di una “nuova Terra”, quindi, è incredibilmente vicina.
Puntando i riflettori sulle dinamiche attuali dell’esplorazione spaziale, senza tralasciare il ruolo dei mass media e l’influenza della politica, questo libro ci condurrà in un viaggio straordinario nel cosmo, attraverso pianeti inospitali e stelle lontanissime, alla ricerca di luoghi capaci di ospitare la vita, o che magari già la ospitano.
1. Se lo fa la natura, puoi farlo anche tu - 2. Pianeti impossibili - 3. Un pianeta dopo l’altro - 4. Sogni spaziali - 5. Una corsa al ribasso - 6. Strani nuovi mondi - 7. Chi fa da sé... - 8. La guerra dei titoli - 9. Il disastro - 10. La fine dell’inizio - Ringraziamenti - Glossario - Indice analitico
Una corsa al ribasso
Quando fu annunciata la scoperta di 51 Pegasi b e degli altri primi esopianeti, l’astronomo Steven Vogt dell’Università della California a Santa Cruz ricorda di aver guardato i dati e aver pensato che, per quanto fossero epocali, la vera posta in gioco non era trovare i gioviani caldi, bensì i pianeti analoghi alla Terra. Si trattava di una corsa al ribasso, ma non per questo era un’impresa facile: gli spettroscopi avrebbero dovuto essere almeno dieci volte più precisi.
Anche Geoffrey Marcy ne era consapevole. Vogt era stato il suo supervisore di dottorato all’Università della California. I due non soltanto erano rimasti in contatto, ma entrambi usavano l’osservatorio Lick. Vogt aveva costruito lo spettrometro Hamilton che Marcy aveva usato per la sua tesi e di cui ora si serviva insieme a Butler per scoprire esopianeti. Ben prima della scoperta di 51 Pegasi b, Marcy si era “lamentato” con lui che lo spettrometro Hamilton non era abbastanza preciso per ciò che desiderava fare davvero: scoprire altre Terre. Vogt era d’accordo, ma non c’era molto che potesse fare. Sapeva esattamente come modificare lo strumento per renderlo più preciso, tuttavia all’osservatorio mancavano la tecnologia e le risorse necessarie. Oltretutto, all’epoca si stava preparando a costruire un nuovo spettrometro per il potente osservatorio Keck che stava nascendo alle isole Hawaii.
L’osservatorio Keck era impressionante da vedere. Situato sulla cima del vulcano inattivo Mauna Kea, sull’isola di Hawaii, era costituito da due telescopi, ciascuno con uno specchio di 10 metri di diametro. Negli anni ’90, era impossibile costruire specchi del genere a partire da un’unica lastra di vetro: ogni occhio gigantesco consisteva perciò di 36 specchietti esagonali, tenuti insieme da strutture di supporto controllate da un computer. Le cupole bianche sfavillanti che ospitavano questi telescopi erano due edifici imponenti, alti come palazzi di otto piani.
I telescopi furono finanziati dalla W.M. Keck Foundation, un’organizzazione filantropica fondata nel 1954 da William Myron Keck, imprenditore nel settore petrolifero, con l’auspicio di promuovere progetti scientifici tali da offrire all’umanità benefìci di lunga durata. E negli anni ’90, avere una coppia di telescopi affiancati, entrambi da 10 metri, era praticamente il sogno di ogni astronomo.
Il primo telescopio cominciò le osservazioni nel 1993, mentre il suo gemello fu messo online nel 1996. Il progetto era gestito dall’Università della California (da cui il coinvolgimento di Vogt) e dal California Institute of Technology (Caltech). Il lavoro di Vogt consisteva nel progettare e costruire uno spettrometro di prim’ordine per questo telescopio di prim’ordine. Il dispositivo fu soprannominato HIRES (High Resolution Echelle Spectrometer) e, sebbene fosse stato ideato per essere uno strumento versatile, utilizzabile in qualsiasi ramo dell’astronomia, Vogt capì che sarebbe stato un potente cacciatore di pianeti.
Per Marcy, la notizia era allo stesso tempo buona e cattiva. Per la prima volta, la sua decisione di lavorare in una piccola università confortevole si stava rivelando un ostacolo: pur avendolo molto aiutato all’inizio del progetto, ora Marcy desiderava ardentemente del tempo di osservazione al Keck con HIRES. Il problema era che, per ottenerlo, bisognava essere un professore dell’Università della California.
Vogt gli venne in aiuto. Insegnava proprio lì, e fece a Marcy e a Butler un’offerta. Dovevano unire le forze. Se Marcy e Butler acconsentivano a costruire una cella allo iodio che facesse funzionare il loro software per il rivelamento, Vogt l’avrebbe incorporata nello spettrometro HIRES. Fin dall’inizio, sarebbero riusciti a misurare le velocità stellari con una precisione di qualche metro al secondo. Pur essendo ancora insufficiente per la ricerca di analoghi terrestri, la dimensione dei potenti telescopi del Keck avrebbe però consentito di osservare le stelle più lontane e fioche mai viste prima. Dal canto suo, Vogt avrebbe dedicato tutto il proprio tempo di osservazione alla ricerca di pianeti; per quanto fosse coinvolto in molti altri progetti di astronomia, che avrebbero tutti tratto beneficio da osservazioni con un telescopio da 10 metri, comprese che il destino lo aveva messo nel posto giusto per trovare pianeti. Come non fare tutto il possibile per promuovere un tale momento storico per la scienza? Marcy e Butler non potevano che accettare il suo aiuto.
Il trio si mise immediatamente al lavoro, sognando di trasformare il Keck in un’importante macchina trova-pianeti. Il problema era ottenere abbastanza tempo di osservazione. Vogt riusciva ad avere 5 o 10 notti all’anno, nemmeno lontanamente sufficienti per il tipo di impresa che avevano in mente.
Poi, nel 1996, tutto si sistemò al meglio. La NASA investì nel Keck, pagando un sesto del valore dei telescopi. L’agenzia spaziale voleva mettersi a cercare pianeti per rifarsi la reputazione.
Negli anni ’90, la NASA era un’organizzazione sotto assedio, criticata per la mancanza di un orientamento preciso. I tempi d’oro dei viaggi sulla Luna erano ormai lontani, eppure, dopo vent’anni, rappresentavano ancora l’apice del successo per l’agenzia. Il 20 luglio 1989, giorno del ventesimo anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11, il presidente George Bush Senior, con gli astronauti Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins seduti dietro di lui, parlò alla nazione: davanti al National Air and Space Museum dello Smithsonian lanciò un appello alla NASA affinché rilanciasse le esplorazioni spaziali. Bush chiese la costruzione di una stazione spaziale americana, il ritorno dell’uomo sulla Luna e un viaggio su Marte. Disse che il destino dell’umanità era l’esplorazione e quello dell’America era esserne il leader.
Rinacquero così le ambizioni spaziali americane e la NASA non perse tempo. Nel mese di novembre dello stesso anno, l’agenzia aveva stilato un piano d’azione per soddisfare le richieste del presidente. Ci volevano soltanto 500 miliardi di dollari. 500 miliardi di dollari! Una quantità di soldi sbalorditiva, anche se spesa in venti o trent’anni. Era ovviamente una richiesta impossibile, ma senza un simile obiettivo di lungo termine a cosa sarebbe servita la NASA?
Nel 1990, un rapporto presidenziale suggerì all’agenzia di concentrare i propri sforzi sull’osservazione della Terra e dell’Universo circostante. Il testimonial di questo approccio avrebbe dovuto essere il telescopio spaziale Hubble, lanciato nell’aprile di quell’anno, ma le primissime osservazioni rivelarono che il progetto da un miliardo di dollari risentiva di un errore gravissimo: lo specchio aveva la forma sbagliata. E questa era soltanto una delle cose che andavano male.
C’era anche lo Space Shuttle, che trasportava gli astronauti su e giù da un’orbita intorno alla Terra, ma sembrava non avere molto altro da fare. Nonostante le promesse, nel 1992, a causa di un superamento del budget, non era stato lanciato ancora alcun modulo della stazione spaziale americana. La crisi della NASA era così profonda che l’organizzazione sembrava sull’orlo del tracollo finale. Qualcosa doveva cambiare.
La svolta arrivò grazie a Daniel Goldin. Nel 1962, da poco laureato, Goldin era entrato nella NASA per studiare i meccanismi di propulsione di un veicolo per il trasporto nello spazio di equipaggi umani. Negli ultimi giorni della presidenza di George Bush, fu nominato amministratore della NASA, la carica più importante dell’agenzia, e si mise alla ricerca di progetti realizzabili, stimolanti e dai costi ragionevoli.
Coordinò la prima missione di manutenzione del telescopio spaziale Hubble: i difetti ottici furono riparati e l’osservatorio fu riportato all’altezza delle specifiche di progettazione. Seguendo le direttive dell’appena eletto presidente Clinton, Goldin negoziò partnership internazionali con quattro altre agenzie spaziali (la russa Roscosmos, l’europea ESA, la giapponese JAXA e la canadese CSA) per trasformare l’American Freedom Space Station nella Stazione Spaziale Internazionale, operativa ancora oggi. Successivamente, si mise alla ricerca di un modo per rappresentare l’agenzia con una sola, indimenticabile immagine, così come negli anni ’60 e ’70 era stato per la classica foto Earthrise, in cui la Terra compare sopra l’orizzonte lunare.
La fotografia Earthrise era stata scattata il giorno della vigilia di Natale del 1968 dal modulo di comando dell’Apollo 8. A bordo, gli astronauti Frank Borman, Jim Lovell e William Anders stavano sorvolando la Luna per la quarta volta – erano i primi a essere andati così lontano nello spazio – e Anders stava scattando fotografie della superficie bucherellata di crateri con una macchina fotografica.
«E ora si balla», aveva detto Borman, annunciando l’inizio di una manovra di routine. I registratori di bordo avevano catturato lo sbuffo di un propulsore, come un sospiro improvviso, mentre la navicella aveva cominciato a ruotare lentamente. A quel punto Anders aveva esclamato: «O mio Dio, guardate quell’immagine laggiù!». Pochi istanti prima si era chiesto se un cratere da impatto sulla superficie lunare fosse davvero vulcanico, ma il movimento gli stava mostrando qualcosa di molto più sensazionale.
«La Terra si sta alzando», aveva detto con eccitazione. Dal fianco argenteo della Luna, il luminoso pianeta blu stava sorgendo nel cielo. La distanza faceva sembrare il nostro possente mondo soltanto una piccola sfera fragile. Pur ospitando all’epoca 3,5 miliardi di persone, uno qualsiasi degli astronauti poteva coprirlo semplicemente alzando il pollice.
«Wow, che bello!», aveva aggiunto Anders, alzando la macchina fotografica per immortalare l’istante, mentre Borman aveva scherzato: «Ehi, non scattare, non è programmata!».
Anders aveva scattato una foto in bianco e nero, poi aveva chiesto a Lovell di passargli una pellicola a colori. Qualche istante dopo, Anders l’aveva caricata nella macchina e aveva scattato l’immagine iconica: Earthrise, il sorgere della Terra. Ancora oggi la foto è un simbolo universale delle esplorazioni spaziali, immortalata su poster, tazze e magliette. Chiaramente incarnava i primi successi della NASA e il fatto che negli anni ’90 non fosse ancora stata sostituita sembrava sottolineare la fase di stallo dell’agenzia.
Per questi motivi, Goldin voleva una nuova immagine che raccontasse i traguardi successivi raggiunti dalla NASA e avesse la stessa carica emotiva di Earthrise. La scoperta degli esopianeti e il grande interesse suscitato gli diedero l’idea perfetta. Voleva un’immagine di una nuova Terra. Nessuno sapeva dove trovare un simile pianeta, né se esistesse davvero; con sempre più esopianeti scoperti ogni giorno, tuttavia, la maggior parte degli astronomi pensava che fosse soltanto questione di tempo prima che una nuova Terra saltasse fuori, e Goldin voleva che la NASA si dedicasse a scattarne un ritratto. Prima però la dovevano scovare. Qui entrava in gioco l’osservatorio Keck.
| 1 novembre 2018 | L'indice |
| 1 ottobre 2018 | Leggere:tutti |
| 8 Giugno 2018 | Adolgiso.it |
| 18 Novembre 2020 | La Sicilia |
 Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente
Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente