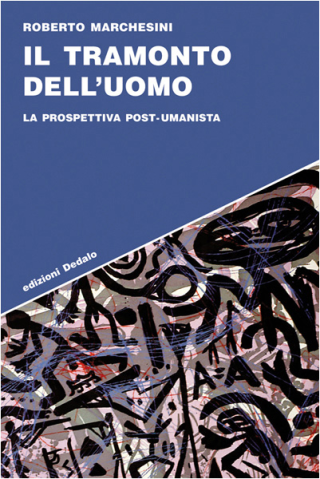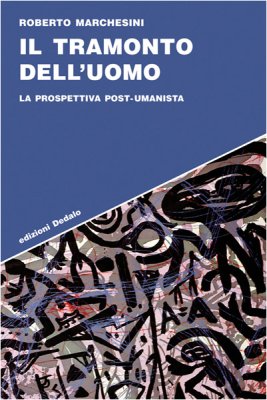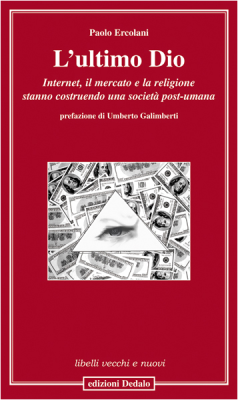Il tramonto dell'uomo
La prospettiva post-umanista
Il nostro corpo viene costantemente rimodellato attraverso le nuove tecnologie: il confine naturale della vita e l’orizzonte dell’esperienza umana si aprono a nuove dimensioni.
- Collana: Strumenti / Scenari
- ISBN: 9788822053817
- Anno: 2009
- Mese: luglio
- Formato: 14 x 21 cm
- Pagine: 216
- Tag: Scienza Filosofia Tecnologia Etica
Il libro esamina i grandi cambiamenti che le nuove tecnologie stanno approntando rispetto ai concetti di base dell’esistenza umana, ponendo in evidenza i più importanti fuochi di metamorfosi e gli slittamenti di significato inaugurati dalle prassi biomediche e dall’immaginario del virtuale. Termini come cyborg, morte cerebrale, intelligenze non umane, clone, avatar, identità mutante mettono a dura prova le tradizionali coordinate antropologiche e le cornici epistemologiche chiamate a interpretarli. Ci troviamo di fronte a una profonda rivoluzione culturale capace di affascinare taluni e atterrire altri, che richiede però un’attenta riflessione nei suoi prospetti paradigmatici e nei suoi innumerevoli risvolti. Non è possibile affrontare le grandi questioni di bioetica riferibili alla vita e alla morte, ai concetti di accanimento terapeutico ed eutanasia, agli scenari inaugurati dall’ingegneria genetica e dalle staminali senza comprendere le modifiche che la dimensione umana ha vissuto negli ultimi due decenni. La filosofia post-umanista offre delle risposte nuove rispetto agli scenari che si presentano, conoscerle vuol dire avere degli strumenti in più per affrontare le sfide del XXI secolo.
Umanismo e post-umanismo
Il riferimento all’uomo come operatore di significato non può dare risposte alla distruzione del pianeta, alla solipsia individualistica, all’incapacità di comprendere la diversità, per il motivo molto semplice che è stato proprio l’antropocentrismo come progetto filosofico a dar vita a queste criticità. Persino il modo di tracciare un quadro diagnostico, vale a dire di capire la natura del problema, risente del paradigma filosofico di riferimento. Leggere la tecnopoiesi come potenziamento dell’uomo pone, infatti, quesiti assai differenti rispetto all’interpretarla co me ibridazione dell’uomo: nel primo caso infatti ci misuriamo con la capacità di controllare (nel senso di saper gestire il controllo) il nostro dominio sul mondo, nel secondo di comprendere le problematicità emergenti dai campi di slittamento della condizione umana. In altre parole un’ibridazione struttura un nuovo fronte declinativo dell’umano, inaugura un orizzonte di opportunità, ci mette di fronte a rischi sconosciuti, ricalibra cioè per intero la nostra condizione esistenziale alimentando i centri del bisogno-responsabilità non quelli della potenza.
In altre parole un’ibridazione indica una condizione di coniugazione dell’uomo non di semplice potenziamento, il che significa che secondo l’approccio post-umanistico i problemi aperti dallo sviluppo tecnologico in essere sono completamente diversi rispetto alla mera questione del corretto esercizio di gestione o del controllo. E non si tratta semplicemente di richiamare l’attenzione su altri aspetti bensì di mostrare come l’approccio tradizionale rischi di portare fuori strada. È sbagliato affermare che le grandi trasformazioni in biologia o in informatica non pongono quesiti altrettanto rilevanti con cui volenti o nolenti ci dovremo confrontare. In genere gli scienziati non amano turbare l’opinione pubblica; in fondo un clima di ottimismo lavora per loro, come d’altra parte i giornalisti sono sempre tentati dal sensazionalismo poiché catturare l’attenzione è importante quanto saper divulgare. Se non è corretto sminuire la portata dei cambiamenti in atto altrettanto sterile è l’esagerazione giacché ogni trasformazione si appoggia al sostrato che l’ha maturata e lì vi si radica. Non è importante la novità tecnologica, ovvero non è importante in sé, ma come la si affronta e con quali strumenti ermeneutici la si considera. Se rimaniamo ancorati alla concezione di «uomo timoniere» della macchina tecnologica rischiamo di spingere il pedale dell’acceleratore nel momento più critico del processo di integrazione delle nuove coordinate dimensionali.
Peraltro questo atteggiamento diviene comprensibile se riflettiamo sul fatto che l’antropocentrismo umanistico non è semplicemente l’assunzione dell’uomo come misura, sussunzione, fine dell’Universo ma altresì come liberazione dell’uomo da ogni vincolo del non umano per accelerare la realizzazione dell’umano come progetto sincretistico di elevazione. Ecco allora che le ellissi tecnologiche del nostro tempo vengono percepite e vissute, naturalmente con scansioni differenti a seconda della pregnanza proiettiva sul progetto, come uno strumento in più o forse come la sintesi operativa che permette o rende in qualche modo delineabile in concreto ciò che prima era solo vagheggiato. Dovrebbe far riflettere il fatto che il luna park tecnologico approntato dai media negli anni ’90 ha fatto riemergere quei concetti di virtualità dell’uomo che echeggiavano nel pensiero di Pico della Mirandola. I richiami ai primi umanisti, che puntualmente fanno capolino per suffragare l’idea di un post-uomo prossimo venturo, non sono affatto peregrini, sembrano declamare come la tecnoscienza abbia trasformato i loro sogni in realtà. A mio parere nello squadernare le nuove leve di intervento dell’uomo dominus o nel prospettare futuri angeli tecno-mediati in realtà non ci si allontana di un passo dall’Umanismo. Non ci si allontana da quel pensiero fecondo e pericoloso a un tempo che l’uomo sia eccentrico paradossalmente rimanendo al centro.
Dove collocare allora il passaggio, ovviamente se c’è, tra una visione umanistica e una post-umanistica e quali tratti di continuità possono essere rinvenuti tra i due paradigmi? Qui occorre essere molto attenti nel valutare le maglie del progetto umanistico nei suoi presupposti come negli obiettivi, evitando la falsa isonomia tra umanismo e antropocentrismo. Esiste un nesso tra i due nuclei concettuali, ma non dimentichiamo che è stato proprio l’Umanismo a porre le basi per la critica all’antropocentrismo – si pensi, so lo per fare due esempi, alla messa in mora dell’approccio proiettivo nell’interpretazione dei fenomeni grazie alla rivoluzione scientifica o alla discussione sulla strumentalizzazione del mondo e sui rischi connessi operata da parte di molti filosofi tra la seconda metà del XVII secolo e il XVIII secolo. L’Umanismo ha trasformato l’antropocentrismo da sguardo ingenuo sul mondo a progetto filosofico e tra le due prospettive antropocentrate non c’è sovrapposizione e spesso nemmeno contiguità.
La proposta antropocentrica dell’Umanismo è fondata sulla separazione dell’uomo dal mondo, è cioè un progetto di enucleazione dell’uomo e di trasformazione del mondo in satellite strumentale; lo sguardo ingenuo antropocentrico sul mondo è, al contrario, un’immersione proiettiva che applica al mondo le coordinate della prospettiva antropocentrata. La differenza tra le due impostazioni antropocentriche c’è ed è rilevante. L’aspetto che differenzia maggiormente l’approccio umanistico rispetto a quello post-umanistico è la messa in discussione da parte di quest’ultimo del progetto filosofico antropocentrato mentre ciò che accomuna Umanismo e post-umanismo è il rifiuto dell’antropocentrismo come sguardo ingenuo sul mondo, vale a dire la tensione a superare la prospettica dell’uomo come specie in nome di un divenire. Sia nell’impostazione umanistica che in quella post-umanistica cioè si traccia una differenza sostanziale tra l’uomo come prospettica biologica, frutto del retaggio filogenetico, e l’umano come dimensione antropo-poietica. Potremmo dire che nell’individuazione dell’umano come condizione fondata sul divenire e non semplicemente come aderenza al retaggio sta l’indubbia continuità del post-umanismo rispetto all’Umanismo.
L’Umanismo rende magmatica la condizione umana, secolarizza la tensione verso un progetto ontopoietico centrato sull’uomo e, in questo senso, fa emergere la dimensione diacronica, commisura l’esistenza sulla definizione storica. Questo aspetto è sicuramente il tratto più forte di condivisione tra i due paradigmi, giacché si potrebbe persino affermare che la proposta post-umanistica è una lunga discussione sulle caratteristiche dell’immersione nel temporale, nelle scansioni della transitività, ossia del passaggio declinativo, e della transitorietà, ovvero dell’oscillazione verso il molteplice. Già questo apre un dubbio a cui francamente non ci è dato di dare una risposta ultimativa, cioè se non sia più corretto parlare di una sorta di neoumanismo, attraverso la rivisitazione di alcuni aspetti dell’Umanismo, piuttosto che avanzare l’ipotesi di un vero e proprio superamento di paradigma. Ho fatto riferimento alla forte attenzione verso la dimensione diacronica ma non di meno centrale è la separazione tra l’uomo, come condizione biologica, e l’umano come dimensione poietica: si tratta di un aspetto che ipostatizza il concetto di tempo nei predicati umani. Beh, non vi è dubbio che anche in questo vi sia una forte assonanza tra Umanismo e post-umanismo.
Per altri aspetti, tuttavia, la differenza è corposa e dirompente, più coerente con un salto di paradigma e una ridiscussione globale delle coordinate che con una semplice rivisitazione; per questo, al di là della mera questione terminologica, ritengo più pregnante la definizione di post-umanismo, giacché anche il progetto ha subìto un viraggio nei presupposti e negli obiettivi. Il punto di rottura più eclatante sono le tre direttive di co-estensione dell’uomo rispetto al mondo: 1) la concezione di uomo come misura, entità neutra, non declinata e quindi proteica e universale in virtù del suo carattere non specificato; 2) la visione dell’uomo come entità capace di contenere il mondo e quindi di sussumere tutti i predicati della realtà esterna, ovvero di poter raggiungere il mondo per intuizione e deduzione e di poterne formulare delle leggi esaustive; 3) l’idea che l’uomo sia il fine ultimo dell’universo, il suo punto omega e che tutta la realtà non umana sia funzionale al raggiungimento dei suoi fini, con un’inevitabile strumentalizzazione del mondo. Queste tre direttrici sanciscono inevitabilmente un divorzio tra l’uomo e la realtà non umana, nel senso di considerare l’umano come un dominio disgiuntivo e autarchico, da cui discende la necessità-conseguenza di fondare in modo esaustivo l’umano sull’uomo – pur mantenendo la separazione tra i termini – e di interpretare l’antropo-poiesi come un processo di epurazione, decontaminazione, separazione, opposizione. La visione umanistica di uomo co-estensivo al mondo è il vero nodo dell’antropocentrismo filosofico perché nega qualunque apporto delle alterità non umane nella costruzione dei predicati umani, anzi, ritiene che questi ultimi si realizzino tanto più quanto maggiormente si attivi l’operatore di divergenza e di solipsia di specie. Questo è il motivo che porta a trasformare la conoscenza delle alterità come un processo di reificazione (oggetto di studio) e ogni forma di partecipazione o condivisione con esse come un processo di proiezione (antropomorfismo).
Tale divorzio sta alla base delle criticità che l’uomo contemporaneo sta vivendo, vuoi nell’incapacità di cogliere le occasioni che si profilano vuoi nella difficoltà a tratteggiare i rischi o i vincoli presenti. Nella visione umanistica siamo condannati a leggere l’umano come emanazione dell’essenza-uomo, vale a dire ad appoggiarci al mito della purezza e a negligere qualunque ruolo delle alterità non umane che non sia quello strumentale. E qui ovviamente si nascondono i germi più insidiosi rispetto alla nostra capacità di interpretare i cambiamenti in atto e di dare una risposta adeguata alle sfide che il terzo millennio ci apparecchia. Il perché è presto detto. Se facciamo attenzione alle problematicità proprie della contemporaneità ci accorgiamo subito che esse riguardano in primis l’interfaccia tra l’uomo e il mondo, una soglia di interscambio resa più critica, profonda, recrudescente, ricorsiva dalla rivoluzione tecnoscientifica del XX secolo.
Post-umanismo e cultura dell’integrazione
Un esempio per tutti è la questione identitaria, ove – sia chiaro – non è in gioco solo una discussione accademica bensì il modo di considerare gli operatori integrativi. Il mito della purezza conduce a interpretare le identità non come entità dialogiche, vale a dire quali soglie referenziali chiamate ad alimentare l’interscambio come fattore vitale di sopravvivenza, bensì come isole che devono preservare il loro profilo costruendo dei muri ed emergendo attraverso operatori dicotomici. Questa lettura, per quanto rigettata e negata (spesso in modo demagogico e ipocrita), è sempre presente in filigrana perché sostenuta dal principio stesso che il profilo e i predicati siano informati dall’essenza e non dall’ibridazione. Ora è chiaro come detta visione ostacoli qualunque forma di multiculturalismo, perché portata a intenderlo come rischio e non come occasione, come diluizione dell’identità e non come arricchimento della stessa, con la conseguenza di sostanziare sempre nuove forme di xenofobia. L’impressione è che il rifiuto verso il multiculturalismo non decada ma semplicemente metamorfizzi e così facendo si prenda degli spazi temporanei di operatività criptata. Cosa voglio dire? Che il rischio xenofobo va al di là della specifica forma assunta nel qui e ora perché la sua vera matrice sta nel principio di epurazione e, finché ci sarà qualcuno pronto a predicare un qualsivoglia rito di purificazione come percorso per la realizzazione identitaria, inevitabilmente ci sarà spazio per nuove forme di emarginazione e xenofobia.
Quindi è facile capire che in una temperie dove i processi di globalizzazione, nelle loro varie scansioni, vengono accelerati e articolati – vale a dire che non solo aumentano, accrescono il loro ritmo di crescita, mettono in campo fattori sempre più consistenti ma altresì si trovano a coinvolgere campi vieppiù molteplici entrando in profondità nel quotidiano – tale impostazione diviene inevitabilmente foriera di conflitti ancorché sommersi, dove cioè la dialettica del confronto e della condivisione non trovano altra possibilità che assumere i connotati dello scontro e del rifiuto. Non intendo fare un discorso demagogico affermando che l’incontro tra culture o le situazioni di pluralità etnica siano di per sé situazioni di pacifico interscambio: chi lo fa, magari per superficialità o per accaparrarsi consensi, pone una seria ipoteca sugli stessi processi di integrazione, perché di fatto non si adopera per costruire strutture connettive. Il fraintendimento sta nell’interpretazione del concetto di «arricchimento identitario» dove l’apporto referenziale può avvenire non solo attraverso traslazioni di modelli o compensazioni ma anche attraverso lo scacco. Tuttavia c’è arricchimento se anche lo scacco viene posizionato su un campo dialogico attraverso sistemi di integrazione. Orbene il post-umanismo chiarisce questo processo di strutturazione dell’identità attraverso la referenza offerta dall’alterità invertendo l’operatore: dal rito di purificazione al rito di contaminazione.
La risposta umanistica nei conversi dell’integrazione non può che passare attraverso un bivio obbligato: o la convivenza, ove si condivide uno spazio o una dinamica mantenendo pura la propria identità, o l’accettazione della propria fallibilità in nome di un neutralismo connettivo. D’altro canto tale risposta è in grado di reggere nella misura in cui c’è una matrice comune che può fungere da ambiente di incontro. Ma la pretesa di criptare l’identità, in nome di un milieu integrativo quanto più neutro possibile, è un percorso destinato al fallimento, come peraltro il nostro tempo sta sempre più dimostrando. Questo approccio solo in apparenza si prodiga a cercare ambiti di condivisione, partendo dal presupposto che il nocciolo duro dell’identità o, se si vuole, la sua natura autentica abbia una consistenza separativa, divergente e autarchica quindi vada preservata e incasellata quale frutto puro. Nascondere la diversità per facilitare la convivenza o l’integrazione è una scelta sterile e controproducente ma soprattutto chimerica. Ci troviamo di fronte a un rifiuto della diversità e a una finta integrazione perché di fatto si evita accuratamente il processo dialogico-referenziale.
Il modo di affrontare il multiculturalismo proposto dalla filosofia post human è diverso proprio perché non fuorviato dalla coordinata di purezza bensì indirizzato a riconoscere il portato dell’ibridazione nella genesi identitaria. Se l’identità è un commercio, un porto di mare, la soglia della propria casa, il plasmalemma di una cellula, essa esiste in quanto immersa in un processo di interscambio e solo questo suo statuto di interfaccia ne consente l’organizzazione e il metabolismo interno. Voglio dire che, se l’identità è ospitale (e in quanto ospitale), la sua capacità di accoglienza e di estasi è la vera misura della tenuta in termini di riconoscibilità e di potenzialità evolutive. L’espressione dell’identità fa emergere le occasioni e le problematicità integrative e proprio per questo sollecita il processo di integrazione, viceversa la criptazione dell’identità non consente quell’interscambio e quelle proprietà di interfaccia che ne sostanziano la tenuta. Quando si afferma che la diversità è un valore si vuole significare il portato critico della diversità, ovvero la sua potenzialità nel produrre un cambiamento. Orbene non c’è integrazione senza cambiamento, vale a dire senza la predisposizione di ambiti di interscambio e di accoglienza reciproca. Secondo un’impostazione post-umanistica l’integrazione passa perciò attraverso la strada referenziale e, a questo punto, dovrebbe essere chiaro che l’inclusione dell’etero-referenza, quale processo di ospitalità permanente, non significa affatto annichilire la casa, vale a dire la propria identità, ma costruire la casa mantenendo aperta la soglia di ingresso e le finestre.
L’aspetto che caratterizza la proposta post-umanistica è il significato che viene dato alla diversità, una valuta che dev’essere messa in commercio per creare integrazione, giacché quanto più le identità sono condivise tanto più hanno la possibilità non solo di capirsi ma di attivare la reciprocazione referenziale. In altri termini secondo il post-umanismo non si deve aspirare a una situazione univer sale e neutra bensì si deve attivare e mantenere l’espressione identitaria e la condivisione delle differenze. La diversità in altre parole è la vera merce di scambio, ciò che attiva l’evoluzione referenziale e quindi consente la costruzione e l’espressione di ogni identità, ove l’integrazione è più la realizzazione di un comune sentire che un’algida razionale tolleranza dell’altro. In tal senso l’integrazione è anche un sentimento, accettando perciò la problematicità che da questo deriva, sempre in una logica declinativa dell’umano. Sia chiaro, quando parlo di «comune sentire» non intendo necessariamente una sovrapposizione di valori ma una sorta di partecipazione empatica che emerge: 1) da uno stato emozionato e sociale, più che dalla sola comprensione, verso le ragioni dell’altro; 2) dalla voglia di ricercare spazi comuni di espressione e spazi di connessione e di referenza. L’idea post-umanistica fonda perciò l’integrazione non sulla sola razionalità bensì sulla realizzazione di un «connettivo di senzienza» che comprende sì la conoscenza e il dialogo ma non di meno la costruzione di processi di reciprocazione capaci di dar luogo a evoluzioni referenziali dialogiche, basate sulla diversità come valore e non come rischio. In tal senso parliamo di una valorizzazione della diversità come volano di processi connettivi, talvolta problematici ma non di meno utili per dar luogo all’evoluzione referenziata dell’identità, condizione necessaria all’integrazione. Si tratta di un processo articolato ma essenziale considerati gli eventi di globalizzazione in atto: non c’è più spazio per la purezza e ogni appello ad essa è un risuonar di armi.
Dobbiamo riflettere su un punto: lo sviluppo incredibile dei media che si è andato realizzando negli ultimi cinquant’anni rende impraticabile qualunque pretesa separativa, di chiusura, di difesa.
L’unica strategia percorribile è quella integrativa, sempre che non la interpretiamo banalmente come una rinuncia all’espressione della propria identità in nome di un relativismo a 360 gradi e di un universalismo francamente improponibile.
| 20 dicembre 2009 | L'inattuale |
| 30 ottobre 2009 | Il Manifesto |
| 26 ottobre 2009 | La Sicilia |
| 25 luglio 2009 | La Repubblica |
| 30 aprile 2009 | La Sicilia |
 Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente
Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente