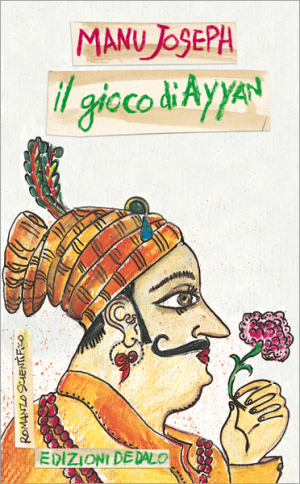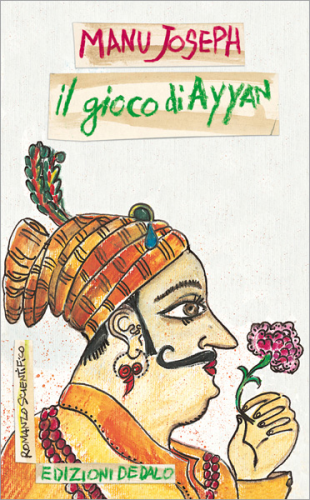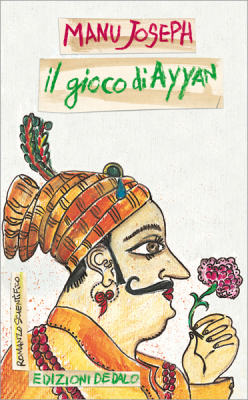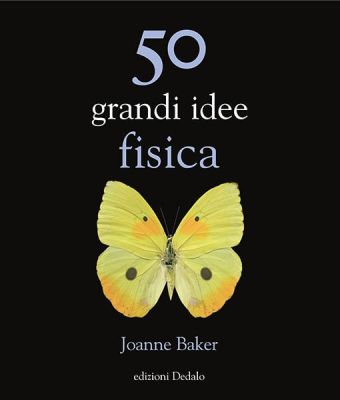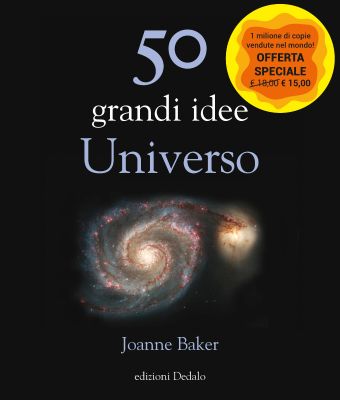Il gioco di Ayyan
Comico e toccante, Il gioco di Ayyan è una feroce satira sul classismo, l’amore, i rapporti umani e la venerazione per la scienza. Una scrittura asciutta e velenosa, un ritratto della vita, della società e della scienza di spiazzante originalità.
- Collana: ScienzaLetteratura
- ISBN: 9788822015013
- Anno: 2011
- Mese: maggio
- Formato: 13 x 21 cm
- Pagine: 344
- Tag: Letteratura Romanzo
Bombay. Ayyan Mani è furbo e intraprendente, ma appartiene alla casta più bassa e può aspirare solo a una vita subalterna e senza prospettive. Ogni mattina esce dall’unica stanza che divide con la moglie Oja e il figlio Adi in un mostruoso complesso di case popolari e raggiunge l’Istituto per la teoria e la ricerca, dove lavora come umile impiegato. Mentre osserva con sarcasmo la “ricerca della verità” a cui si dedicano gli scienziati dell’odiata casta dei bramini, nell’Istituto divampa la guerra fra due fazioni divise da rivalità professionali e personali, ma anche la passione fra l’austero direttore e un’affascinante astrobiologa. Le conseguenze saranno dirompenti anche a causa dell’intervento di Ayyan, che sfrutta spregiudicatamente la situazione per alzare la posta del suo gioco personale: spacciare Adi per un genio, regalando a Oja la possibilità di sognare.
I. Il problema dell’Orecchio gigante - II. Il vecchio nemico del Big Bang - III. Quella dello scantinato - IV. I primi mille numeri primi - V. Gli alieni usavano altri alieni per fare lo yogurt - VI. Un’ultima volta - VII. Il tumulto
Le tavole rotonde erano ovali anche all’Istituto per la teoria e la ricerca. Fu il primo pensiero di Oparna quando arrivò nella sala al secondo piano per la tavola rotonda mensile.
Aveva perso le due precedenti e quindi per lei era la prima. Al centro della stanza c’era una gigantesca scrivania oblunga circondata da uomini seduti in turbolenti cerchi concentrici. Alcuni stavano in piedi e chiacchieravano. Sorridendo, gli inservienti facevano circolare biscotti e tè. Regnavano una grande animazione e una gran ressa. Come in una goccia di sperma sotto un microscopio. Quasi tutti gli scienziati portavano una camicia leggera su pantaloni ampi e comodi. Erano uomini austeri che sapevano di esserlo. Alcuni dei più giovani erano in jeans. Malgrado la strepitosa informalità dell’ambiente, le camicie larghe, le tumultuose chiome bianche e i sandali di cuoio, gli scienziati erano smaccatamente i padroni della stanza, con uno status particolare ben distinto da quello dei segretari che se ne stavano in piedi in silenzio nell’ultimo cerchio concentrico, imbronciati e muti come se i biscotti fossero stati raffermi. Nell’occhio di quel garbato trambusto spiccava la solida figura di Arvind Acharya. I suoi due vicini gli davano le spalle per parlare animatamente con qualcun altro.
Ancora una volta, Acharya era una roccia nella corrente.
Tutta la turbolenza gli girava attorno.
Quando entrò Oparna, si fece silenzio. Lei si avviò con un certo nervosismo verso gli anelli più esterni. Diverse teste grigie e stempiate si voltarono, l’una dopo l’altra. In qualche punto periferico c’erano due segretarie, ma lei aveva l’impressione di essere l’unica donna nella stanza, perché sapeva che ce l’avevano anche gli uomini. Jana Nambodri, con la consueta nube di eleganti capelli argentei, la camicia a maniche corte infilata con cura nei pantaloni di velluto a coste, sedeva al tavolo oblungo esattamente di fronte ad Acharya. Si alzò in piedi e con un gesto ricercato le indicò un posto vuoto in seconda fila. Oparna si fece strada lentamente e con cautela verso la sedia. I vecchi che si trovavano sul suo cammino spostarono le gambe per farla passare. Alcuni si voltarono imbarazzati quando la sua schiena rischiò di sfiorarli sul viso stanco.
Alcuni finsero di continuare a chiacchierare mentre le guardavano il sedere con rispettosa disinvoltura.
«È bengalese?» aveva intenzione di sussurrare un uomo (probabilmente bengalese), ma il silenzio era così assoluto che lo sentirono tutti. Si udirono delle risatine sommesse.
«Storicamente» disse a voce alta Nambodri, «l’unica punizione appropriata per un bengalese è stata una bengalese».
La sala scoppiò in una risata. «Abbiamo dimenticato di dirvelo, signori: lei è la prima donna del nostro corpo docente» annunciò Nambodri.
Uno applaudì. Quando quell’applauso solitario fu sul punto di spegnersi prematuramente, gli altri si unirono per rafforzare la galanteria. L’applauso sfumò in un lungo silenzio rilassato.
Ed era così che la serata si sarebbe svolta, con tumulti festosi che lasciavano il posto a silenzi, silenzi interrotti da profonde domande sull’universo, e domande alleggerite da risate.
Era una lunga tradizione dell’Istituto che gli scienziati si incontrassero il primo venerdì del mese per fare due chiacchiere.
Ayyan Mani contemplava la sala addossato al muro, come molte altre volte, e si scervellava per capire com’era possibile che la verità fosse finita nelle mani di quegli uomini assurdi. Al momento erano infervorati in una discussione sul modo migliore per tagliare una torta e stavano giungendo alla conclusione che tagliarla in fette triangolari, come fanno tutti, non era efficiente. Poi presero in giro uno scienziato francese, che non era in sala, perché aveva detto che l’uomo non avrebbe mai ideato un metodo per prevedere il più grande numero primo. Dopo di che cominciarono a chiedersi cosa avrebbe rivelato il Large Hadron Collider nei pressi di Ginevra.
Ayyan la trovava insopportabile, quella perpetua ricerca della verità. In epoche più semplici, né mendicanti sapienti, né zen prodighi di metafore, figli di Dio o saggi che si trasformavano in formicai, nessuno di quei tizi era stato capace di dire, in un testo chiaro e incisivo pubblicabile sul «Times of India», la ragione per cui esisteva la vita o perché c’era qualcosa invece del nulla. Avrebbero potuto dirlo in un bel paragrafetto e risolvere il mistero una volta per tutte. Ma non l’avevano fatto. Avevano preferito raccontare delle favole. Ora la verità era nelle mani degli uomini presenti in quella stanza, ed erano più incomprensibili degli uomini di Dio. Ayyan era certo che la verità non esistesse.
Esisteva solo la ricerca della verità ed era una ricerca che sarebbe andata avanti in eterno. Era un’occupazione come un’altra.
«A questo mondo la gente fa quello che fa perché non ha niente di meglio da fare» aveva detto una volta a Oja Mani.
«Einstein aveva una cosa che si chiama relatività. Tu lavi il pavimento due volte al giorno».
La tavola rotonda era passata a discutere delle sorti di Plutone.
Oparna non perdeva una parola. Gran parte di ciò che veniva detto le era incomprensibile, ma la malinconia suscitata dal suo ufficio nello scantinato si stava dissipando. Aveva sempre apprezzato la compagnia di uomini che sapevano un sacco di cose. Cercava di capire perché parlassero di Plutone con tanta gravità. Plutone le piaceva. Dai discorsi che sentiva intorno a sé, ricostruì che poco tempo prima il pianeta era stato eliminato dal modello del sistema solare esibito in una mostra in America.
E l’episodio aveva innescato, a quanto pareva non per la prima volta, un acceso dibattito per decidere se Plutone dovesse essere considerato un pianeta o andasse declassato a membro della fascia di Kuiper.
«Plutone è troppo piccolo, troppo piccolo. Potrebbe stare dentro gli Stati Uniti. È minuscolo» esclamò con foga un tizio.
Anche qui, si disse Oparna senza malignità, ogni cosa è una sorta di pene.
Nambodri, che continuava a girarsi verso di lei per lanciarle occhiate da aspirante mentore, le chiese: «Tu che ne pensi, Oparna?».
Lei fece la timida, perché voleva dare l’impressione di non considerarsi qualificata per avere un’opinione. Dopo tutto era solo un’astrobiologa, non un’astronoma. Agli uomini, lo sapeva, quell’umiltà sarebbe piaciuta.
Disse: «Mi dispiacerà molto se Plutone sparisce. Sono dello scorpione». Ancora una volta, si creò un silenzio a causa sua.
Oparna spiegò con un certo imbarazzo: «Lo scorpione è governato da Marte e Plutone».
«Quindi è uno scorpione. Come me» disse sottovoce un uomo nella speranza di suscitare una risata generale, ma per qualche motivo senza riuscirvi.
«Quali sono i tratti dello scorpione?» chiese con scherno una voce, e poi ridacchiò. Partì come una risata chioccia, ma si smorzò quasi subito in un risolino impacciato quando l’autore si rese conto di non essere spalleggiato.
«Intenso, forte, sicuro di sé» disse Nambodri guardando Oparna, «e passionale». Un accenno di risata si spense rapidamente.
Oparna riuscì a sorridere e a mormorare: «L’astrologia non è una scienza, sapete».
«È per questo che non è oggetto di discussione» disse Nambodri.
| 12 giugno 2012 | LIBRICONSIGLIATI.IT (WEB) |
| 01 settembre 2011 | Realtà industriale |
| 31 luglio 2011 | La Repubblica |
| 28 luglio 2011 | L'Espresso |
| 24 luglio 2011 | L'Espresso |
| 19 giugno 2011 | La Gazzetta del Mezzogiorno |
| 05 giugno 2011 | Corriere del Mezzogiorno |
 Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente
Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente