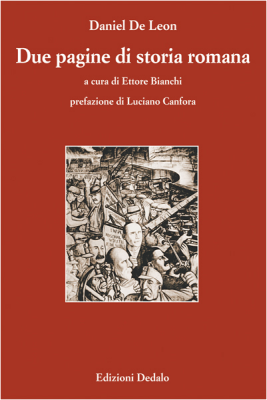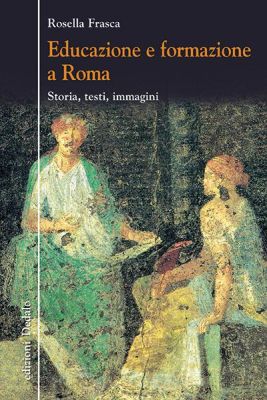Due pagine di storia romana
Magnati plebei e dirigenti sindacali
a cura di Ettore Bianchi
prefazione di Luciano Canfora
La storia politica e sociale dell'antica Roma è per molti versi un laboratorio vivente, attualissimo. Daniel De Leon seppe cogliere, nei suoi scritti di efficacissima divulgazione, un elemento centrale di quella storia e della nostra.
- Collana: Paradosis
- ISBN: 9788822058133
- Anno: 2007
- Mese: novembre
- Formato: 14,5 x 21 cm
- Pagine: 144
- Note: stampato su carta vergata pregiata
- Tag: Storia Storia antica
La storia politica e sociale dell'antica Roma è per molti versi un laboratorio vivente, attualissimo. Grande divulgatore e battagliero militante, organizzatore degli «Industrial Workers of the World», Daniel De Leon seppe cogliere, nei suoi scritti di efficacissima divulgazione, un elemento centrale di quella storia e della nostra: come i vertici del movimento «democratico», divenendo essi stessi parte del ceto dominante, si accordino volentieri con la parte cui dovrebbero opporsi, a danno di quella che dovrebbero rappresentare e difendere. Le «oligarchie» sindacali furono perciò uno dei suoi bersagli. Ragione non ultima, oltre all'efficacia della prosa, che spiega la sua estrema attualità. Ettore Bianchi, che ha tradotto questi due brillanti «saggi popolari», traccia in prefazione un'eccellente biografia di De Leon, dagli esordi come studioso all'omaggio postumo resogli da Lenin con la proposta di un'edizione in Unione Sovietica dei suoi scritti.
Luciano Canfora, Dissipare gli equivoci - Ettore Bianchi, Storia romana e battaglia politica in Daniel De Leon - Un protagonista del movimento operaio - Insegnamenti dalla storia antica - Un'insidiosa strategia padronale - Cautela nella politica delle alleanze - Inconcludenza del riformismo - I guasti politici dell'anarchia - Daniel De Leon, Due pagine di storia romana - I. Pagina prima: Magnati plebei e dirigenti sindacali - Il dirigente sindacale e il magnate plebeo - Il meccanismo politico - Le condizioni sociali - Le divisioni di classe - Fonti dell'espressione economica e dello sfruttamento - I magnati della plebe in Senato - I tribuni della plebe - La legge Publilia - Il decemvirato - La legge di Valerio e Orazio - La legge di Canuleio - Cassio e Manlio - La legge di Licinio - Il tempio della concordia - Scheda del dirigente sindacale - Un colorito “operaio” per il capitalismo - L'alimentazione d'inganni anti-operai - Un colorito “operaio” per le manovre capitalistiche - Occultamento dell'indifferenza borghese per la salute dei lavoratori - Un colorito “operaio” per la violenza borghese - Spezzare la punta della lancia operaia - Il dirigente sindacale e il magnate plebeo - Il compito dell'ora - II. Pagina seconda: Il monito dei Gracchi - Legge delle sequenze rivoluzionarie - La Roma dei Gracchi - La tattica graccana - Atto primo - Atto secondo - Atto terzo - Atto quarto - Atto quinto - Atto sesto - Decalogo della Rivoluzione Proletaria - Avvertimenti dal passato
La Roma dei Gracchi
La Roma dei Gracchi, poco prima del 100 a.C., era la Roma dei decenni dopo il 400 a. C., l’epoca con cui s’era chiusa la precedente conferenza su «Magnati plebei e Dirigenti sindacali», salvo che i mali esistenti s’erano aggravati per altri trecento anni. Tutte le cause che, tre secoli prima, avevano portato a quei mali, erano ancora all’opera, ma col peggioramento ulteriore indotto da trecento anni di impulsi addizionali. A quelle cause se ne dovrebbe aggiungere un’altra, tanto per spiegare e completare il quadro della situazione.
Animata da frivole idee aristocratiche, che avevano fatto presa sulla classe dominante, si diffuse la moda di collezionare vasti pascoli per i bovini e i caprovini, più che aziende agricole. Si portò avanti uno schema di questo tipo: il grano fu importato gratuitamente dalla Sicilia e dalle provincie asiatiche; ciò rese privo di valore, almeno di valore di scambio, il grano coltivato in Italia. Dato che Roma, a quell’epoca, era diventata padrona di tutta l’Italia, questa politica delle importazioni sparse rovina su tutta la penisola: i coltivatori fecero bancarotta; le loro fattorie furono espropriate e andarono ad aggiungersi alle terre dei Romani più influenti; costoro cambiarono il paesaggio agrario italiano in immense distese per le mandrie e lunghe piste per le greggi, entrambe percorse esclusivamente da servi-pastori.
Le condizioni economiche e sociali del tempo sono sintetizzate in modo nitido dalle parole di Tiberio Gracco, che io ho citato nel corso della prima conferenza di questa serie, ad indicare la solenne vacuità delle vittorie dei Magnati plebei, almeno dal punto di vista del “ceto medio” e del popolino. Ripeterò qui ancora una volta quelle parole, per esigenza di completezza (lettura): «Anche le bestie selvagge d’Italia hanno la loro tana dove ritirarsi, ma la brava gente che versa il sangue per la causa di Roma deve accontentarsi dell’aria aperta. Senza tetto, senza fissa dimora, essi vagano da luogo a luogo, con moglie e figli a carico; e i generali non fanno che prenderli in giro quando, alla testa degli eserciti, esortano gli uomini a combattere in nome dei loro sepolcri e dei numi tutelari delle loro case; perché, nella moltitudine, forse non c’è un solo Romano che abbia un altare già appartenuto ai suoi antenati, o disponga di una tomba in cui le loro ceneri riposino. Il soldato semplice combatte e muore per far crescere la ricchezza e lo spreco di chi è più grande di lui. E li chiamano “signori del mondo” quando non posseggono neppure una zolla di terra». Un linguaggio che ricorda quello adoperato dal Nazareno 150 anni più tardi!
Il quadro delle condizioni sociali nella Roma dei Gracchi può essere meglio definito aggiungendo che in Italia, a quel tempo, si diceva ci fosse una massa eterogenea di 14 milioni di schiavi; mentre non più di 2000 famiglie potevano vantare solidi patrimoni; e il disorientamento era arrivato a un punto tale, che un Cavaliere romano fallito (N.d.T.: Tito Vezio) tentò la sorte, liberando i propri schiavi, facendosi proclamare loro re e scatenando una rivolta servile, la quale, naturalmente, fu subito soffocata…
Per quanto riguarda la situazione politica, essa era rimasta invariata, eccetto che per una circostanza, che è importante menzionare, perché ha qualche attinenza coll’argomento di stasera. Quello romano, come la maggior parte degli imperi dell’Antichità, era un impero cittadino: analogamente ad Atene, Sparta, Cartagine, etc. Roma aveva un governo su base cittadina e uno spazio economico su base cittadina; e si potrebbe dire che essa era regolata da principi democratici, nel senso che tutti coloro che avevano voce in capitolo sulla cosa pubblica potevano esprimersi direttamente, presentandosi nel Foro, al mercato, in particolari sedi pubbliche, e là manifestando i loro voti. Finché Roma si era limitata ad assorbire delle tribù limitrofe, il cittadino romano che si fosse insediato sui territori di nuova acquisizione aveva potuto, con relativa comodità, apparire a Roma in tempo d’elezioni, o nei giorni nei quali si doveva votare e far udire la sua voce; tuttavia, nella misura in cui i territori conquistati erano sempre più lontani, la diretta partecipazione alle assemblee diventava più difficoltosa; quando, infine, tutta l’Italia fu possedimanto romano, i coloni, persino quelli con la cittadinanza romana, vennero de facto, se non de jure, privati del diritto di voto: la presenza nel Foro uscì dalla loro portata.
In qualche modo, la mentalità degli antichi sbatteva il muso (lett. «correva in faccia a un muro sordo») contro questo problema; la civiltà moderna l’ha risolto grazie al governo rappresentativo. A Washington, per esempio, sono emanate le leggi che amministrano questo grande paese, infinitamente più vasto dell’Italia che Roma possedeva; le leggi procedono da Washington, ma non è la popolazione di Washington che fa le leggi; le leggi sono emesse dai rappresentanti dell’intera Nazione, selezionati dalla popolazione nel suo complesso; e, in questo senso, è vero che «il Popolo è il Legislatore»: se le leggi che entrano in vigore non gli vanno bene, la colpa è sua. Un paese può oggi comprendere tanti cittadini attivi che sarebbe impossibile incontrarsi tutti e legiferare assieme; e tuttavia, per quanto risiedano in zone remote, essi possono esercitare il loro diritto di voto e di controllo sulle leggi nazionali: è il governo rappresentativo che lo consente.
L’Antichità non ebbe alcuna nozione di ciò. Se il cittadino romano vivente nella periferia italiana non conservò se non un diritto di voto potenziale, nel senso che tale diritto diventava attuale solo con la presenza fisica del soggetto in Roma, gli Italici che non erano stati ridotti in schiavitù divennero una sorta di “paria” politici: essi erano etero-diretti da Roma. Questa dipendenza portò una sequela di spiacevoli conseguenze: economicamente, la popolazione italiana, Roma inclusa, era divisa tra la plutocrazia dei grandi proprietari fondiari e la classe dei proletarii, con il ceto medio che non contava un bel niente; ma le due classi fondamentali si ripartivano ulteriormente in due campi ostili, la spaccatura fra i quali era definita dal diritto di cittadinanza romana: da un lato si misero gli abitanti di Roma, ricchi e poveri insieme, dall’altro ci furono gli Italici residenti fuori Roma, ricchi e poveri insieme. Ebbene, dopo 300 anni di abitudine, che si erano sedimentati nelle teste come un lento deposito alluvionale, il cencioso nullatenente romano finì col considerarsi un pezzetto del blocco dominante, unito al plutocrate romano da un comune destino di superiorità politica sulle moltitudini libere che vivevano pure in Italia, ma fuori di Roma.
Abbiamo visto, nel corso della conferenza su «Magnati plebei e Dirigenti sindacali», le dannose conseguenze del pregiudizio che permise al Plebeo ricco, con la scusa della comune denominazione “popolare”, di gettare fumo negli occhi (lett. «di spingere la lana sugli occhi») ai suoi “amici plebei”, vale a dire ai proletarii e al ceto medio; così come, ai nostri giorni, il Dirigente sindacale inganna i suoi “compagni operai”, con la scusa della comune esperienza lavorativa. Il caso è lo stesso: ogni qual volta fu avanzata la richiesta di garantire il pieno diritto di voto agli Italici, l’oppresso popolino di Roma si unì ai suoi oppressori, nel violento rifiuto di condividere con dei forestieri “la porpora del comando”.
Spero di aver fatto abbastanza chiarezza sul fatto che la congiuntura intorno al 100 a. C., con cui si confrontarono i Gracchi, aveva oltrepassato lo stadio delle riforme: nessun rattoppo poteva più tenere; nessuna emanazione di norme, né attesa per il lento dispiegarsi dei loro effetti, poteva intaccare i mali che affliggevano Roma e, con Roma, le sue dipendenze in Italia; i giorni dei metodi legali erano finiti. Tutte le volte che un popolo giunge al punto dell’esasperazione, le Istituzioni cessano d’esistere, si riducono ad ombre, e non resta altro che l’usurpazione del potere. In quei frangenti drammatici, nessuna scelta è all’ordine del giorno, fuorché la Rivoluzione.
Tali erano le condizioni con cui i Gracchi si dovettero confrontare, e che s’applicarono a correggere. Furono essi consapevoli della natura dell’impegno che li attendeva? Compresero essi le qualità, vale a dire le opportunità e deficienze tattiche, del materiale umano che avevano a disposizione per realizzare il loro compito? Formulando queste due domande, io sto dividendo in due parti un’unica questione, che di per sé sarebbe indivisibile, come lo sono il retro e il verso di una medaglia o i due lati opposti di un medesimo oggetto: il compito da svolgere e gli elementi necessari per svolgerlo. Compresero i Gracchi questo nesso? Vi mostrerò che non lo compresero; e dalla serie di sbagli che quelli commisero, nonché dalle terribili conseguenze dei loro sbagli, noialtri, nella Roma dei nostri giorni, dovremmo ricavare un avvertimento.
 Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente
Articolo acquistabile con Carta cultura giovani e merito e Carta del Docente